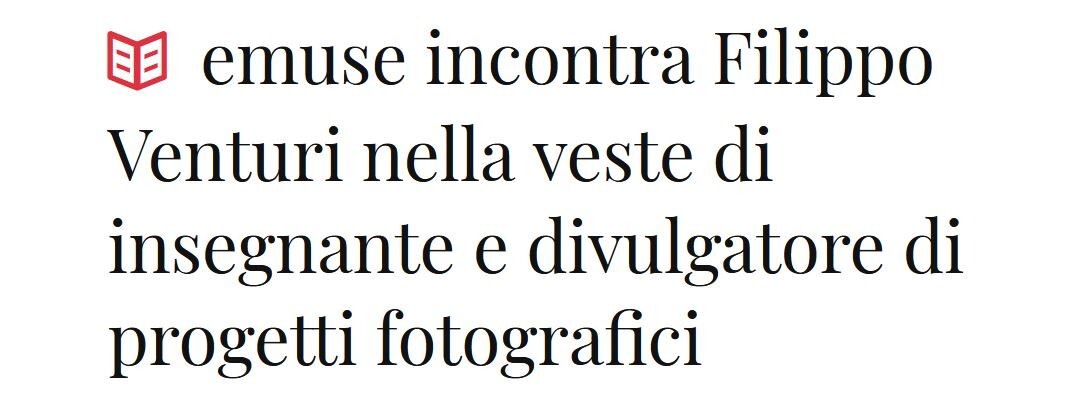Mirino
Un uomo senza mani bussa alla mia porta per vendermi una foto della mia casa. A parte gli uncini cromati, è un uomo sulla cinquantina dall’aspetto ordinario.
“Come ha perso le mani?” chiedo, dopo aver saputo cosa voleva.
“Quella è un’altra storia” dice lui “La vuole questa foto o no?”.
“Venga dentro” dico io “Ho appena fatto il caffè.”
Ho appena fatto anche della gelatina alla frutta. Ma non glielo dico.
“Approfitto della toilette, se posso.” Dice l’uomo senza mani.
Voglio vedere come riesce a tenere una tazza. Già so come fa con la macchina fotografica. È una vecchia Polaroid, grande e nera. La tiene legata a delle cinghie di pelle che gli passano oltre le spalle e si incrociano sulla schiena, così che la fotocamera sia assicurata sul petto. Si piazza sul marciapiede di fronte alla vostra casa, centra la casa nel mirino, preme il bottone con uno degli uncini, ed ecco che salta fuori la fotografia.
L’ho osservato dalla finestra, capite?
“Dove ha detto che si trova il bagno?”
“Giù di là, a destra.”
Piegandosi, ingobbendosi tutto, riesce a liberarsi dalle cinghie. Mette la fotocamera sul divano e si rassetta la giacca.
“Può dare un’occhiata a questa nel frattempo.”
Prendo la fotografia che mi porge. Si vede un rettangolino di prato, il vialetto, il garage, le scalette d’ingresso, la finestra panoramica e la finestra della cucina, dalla quale l’ho osservato.
Mi chiedo perché dovrei volere un’istantanea di questa tragedia.
Guardo un po’ più da vicino e vedo la mia testa, la mia testa, dentro la finestra della cucina.
Vedermi lì, così, mi ha fatto riflettere. Ve lo assicuro, sono cose che fanno riflettere.
Sento il rumore dello sciacquone. Arriva nel salotto, sorridendo e chiudendosi la lampo, un uncino che tiene la cintura, l’altro che piega la camicia.
“Cosa ne pensa allora?” dice “Non male, no? Secondo me è venuta bene. Sono bravo, eh? Ammettiamolo, ci vuole un professionista.”
Si sistema il cavallo dei pantaloni.
“Ecco il suo caffè.” Dico.
Lui dice: “Lei vive da solo, giusto?”.
Osserva il soggiorno. Scuote la testa.
“È dura, è dura.” Dice.
Si siede accanto alla fotocamera, appoggia la schiena con un sospiro e sorride, come se sapesse qualcosa che non mi avrebbe rivelato.
“Beva il caffè” dico io.
Sto cercando qualcosa da dire.
“Tre ragazzini sono passati da qui, volevano dipingere il mio indirizzo sul marciapiede. Chiedevano un dollaro per farlo. Non è che lei ne sa qualcosa?”.
L’ho sparata un po’ a caso, ma lo osservo bene lo stesso.
Si china in avanti, serio in volto, la tazza in equilibrio tra gli uncini. La appoggia sul tavolino.
“Lavoro da solo” dice “sempre fatto, sempre lo farò. Cosa sta cercando di dire?” dice.
“Pensavo ci fosse un collegamento.” Dico io.
Ho mal di testa. So che il caffè non aiuta, ma la gelatina di frutta a volte sì. Riprendo in mano la fotografia.
“Ero in cucina” dico “di solito sto sul retro.”
“Succede sempre,” dice lui “quindi hanno preso e l’hanno lasciata, giusto? Ora guardi me, io lavoro solo. Allora cosa ne dice? La vuole la fotografia?”
“Si, la compro” dico.
Mi alzo e raccolgo le tazze.
“Certo che la compra.” Dice lui “Io, per esempio, ho una stanza in centro. Niente di che. Salgo su un autobus, faccio il giro della periferia, e quando ho finito il lavoro mi sposto in un’altra città. Capisce cosa le sto dicendo? Una volta avevo dei figli. Proprio come lei.”
Aspetto con le tazze in mano e lo guardo lottare per alzarsi dal divano.
Dice: “Loro mi hanno ridotto così.”
Osservo con attenzione quegli uncini.
“Grazie per il caffè e per il bagno. Io la capisco, sa.”
Solleva e abbassa i suoi uncini.
“Me lo dimostri” dico io “Mi dimostri quanto. Faccia altre foto, a me e alla casa.”
“Non funzionerà,” dice l’uomo “Loro non torneranno.”
L’ho aiutato lo stesso con le cinghie.
“Posso farle un’offerta speciale,” dice lui “Tre per un dollaro. Se le faccio di meno ci rimetto.”
Usciamo fuori. Lui mette a punto l’otturatore. Mi dice dove sistemarmi e iniziamo il lavoro.
Ci muoviamo intorno alla casa. Meticolosamente. A volte mi metto di profilo, altre volte guardo dritto l’obiettivo.
“Bene,” dice lui “Così va bene,” dice, fino a quando non terminiamo il giro della casa e siamo di nuovo davanti all’ingresso. “Ne ho fatte venti. Sono abbastanza.”
“No,” dico io “Sul tetto” dico.
“Gesù,” dice lui. Dà un’occhiata su e giù per la strada. “Come no,” dice “ora fa sul serio!”
Dico: “Baracca e burattini, tutto. Se ne sono andati con tutto.”
“Guardi questi!” dice l’uomo, sollevando di nuovo gli uncini.
Vado dentro e prendo una sedia. La sistemo vicino al garage. Ma non è alta abbastanza. Allora prendo una cassa e la metto sulla sedia.
Si sta bene in cima al tetto.
Mi alzo in piedi e mi guardo intorno. Saluto e l’uomo senza mani mi fa un cenno con gli uncini.
Poi vedo dei sassi. C’è come un piccolo nido di sassi tutt’attorno al camino. Sapete i bambini, si divertono a tirarli lassù pensando di centrare il camino.
“Pronto?” faccio io e prendo un sasso e aspetto fino a quando non mi vede nel mirino.
“Pronto!” risponde lui.
Porto il mio braccio all’indietro e urlo: “Ora!” Tiro quel figlio di puttana più lontano che posso.
“Non so,” lo sento gridare “Non faccio mai foto in movimento.”
“Ancora!” urlo io e prendo un altro sasso.
Viewfinder
A man without hands came to the door to sell me a photograph of my house. Except for the chrome hooks, he was an ordinarylooking man of fifty or so.
“How did you lose your hands?” I asked after he’d said what he wanted.
“That’s another story,” he said. “You want this picture or not?”
“Come in, “I said. “I just made coffee.”
I’d just made some Jelly, too. But I didn’t tell the man I did. “I might use your toilet,” the man with no hands said.
I wanted to see how he would hold a cup.
I knew how he held the camera. It was an old Polaroid, big and black. He had it fastened to leather straps that looped over his shoulders and went around his back, and it was this that secured the camera to his chest. He would stand on the sidewalk in front of your house, locate your house in the viewfinder, push down the lever with one of his hooks, and out would pop your picture.
I’d been watching from the window, you see.
“Where did you say the toilet was?”
“Down there, turn right.”
Bending, hunching, he let himself out of the straps. He put the camera on the sofa and straightened his jacket.
“You can look at this while I’m gone.”
I took the picture from him.
There was a little rectangle of lawn, the driveway, the carport, front steps, bay window, and the window I’d been watching from in the kitchen.
So why would I want a photograph of this tragedy?
I looked a little closer and saw my head, my head, in there inside the kitchen window.
It made me think, seeing myself like that. I can tell you, it makes a man think.
I heard the toilet flush. He came down the hall, zipping and smiling, one hook holding his belt, the other tucking in his shirt.
“What do you think?” he said. “All right? Personally, I think it turned out fine. Don’t I know what I’m doing? Let’s face it, it takes a professional.”
He plucked at his crotch. ”
Here’s coffee, “I said.
He said, “You’re alone, right?”
He looked at the living room. He shook his head.
“Hard, hard,” he said.
He sat next to the camera, leaned back with a sigh, and smiled as if he knew something he wasn’t going to tell me.
“Drink your coffee,” I said.
I was trying to think of something to say.
“Three kids were by here wanting to paint my address on the curb. They wanted a dollar to do it. You wouldn’t know anything about that, would you?”
It was a long shot. But I watched him just the same.
He leaned forward importantly, the cup balanced between his hooks. He set it down on the table.
“I work alone,” he said. “Always have, always will. What are you saying?” he said.
“I was trying to make a connection,” I said.
I had a headache. I know coffee’s no good for it, but sometimes Jelly helps. I picked up the picture.
“I was in the kitchen,” I said. “Usually I’m in the back.”
“Happens all the time,” he said. “So they just up and left you, right? Now you take me, I work alone. So what do you say? You want the picture?”
“I’ll take it,” I said.
I stood up and picked up the cups.
“Sure you will,” he said. “Me, I keep a room downtown. It’s okay. I take a bus out, and after I’ve worked the neighborhoods, I go to another downtown. You see what I’m saying? Hey, I had kids once. Just like you,” he said.
I waited with the cups and watched him struggle up from the sofa.
He said, “They’re what gave me this.”
I took a good look at those hooks.
“Thanks for the coffee and the use of the toilet. I sympathize.” He raised and lowered his hooks.
“Show me,” I said. “Show me how much. Take more pictures of me and my house.”
“It won’t work,” the man said.
“They’re not coming back.” But I helped him get into his straps.
“I can give you a rate,” he said. “Three for a dollar.” He said, “If I go any lower, I don’t come out.”
We went outside. He adjusted the shutter. He told me where to stand, and we got down to it.
We moved around the house.
Systematic. Sometimes I’d look sideways. Sometimes I’d look straight ahead.
“Good,” he’d say. “That’s good,” he’d say, until we’d circled the house and were back in the front again. “That’s twenty. That’s enough.”
“No,” I said. “On the roof,” I said.
“Jesus,” he said. He checked up and down the block. “Sure,” he said. “Now you’re talking.”
I said, “The whole kit and caboodle. They cleared right out.”
“Look at this!” the man said, and again he held up his hooks.
I went inside and got a chair. I put it up under the carport. But it didn’t reach. So I got a crate and put the crate on top of the chair.
It was okay up there on the roof.
I stood up and looked around. I waved, and the man with no hands waved back with his hooks.
It was then I saw them, the rocks. It was like a little rock nest on the screen over the chimney hole. You know kids. You know how they lob them up, thinking to sink one down your chimney.
“Ready?” I called, and I got a rock, and I waited until he had me in his viewfinder.
“Okay!” he called.
I laid back my arm and I hollered, “Now!” I threw that son of a bitch as far as I could throw it.
“I don’t know,” I heard him shout. “I don’t do motion shots.”
“Again!” I screamed, and took up another rock.